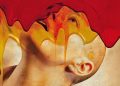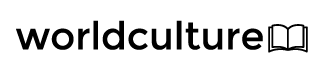Il nuovo film di Noah Baumbach, presentato in concorso a Venezia 82, racconta la storia del divo hollywoodiano Jay Kelly (George Clooney, ispirato e consapevole) durante un viaggio in Europa alla ricerca di sé stesso insieme al suo manager (Adam Sandler, sufficiente ma scolastico) e alla sua assistente (Laura Dern, capace e precisa).
L’aspetto più interessante della pellicola è sicuramente un certo recupero nostalgico della centralità della figura dell’attore statunitense. Tutte i momenti in cui il protagonista – che non a caso somiglia nel nome a Gene Kelly, una delle star più brillanti del cinema classico americano – si rapporta con i suoi fan (ad esempio la simpatica e positivamente leggera sequenza ambientata in treno) sembrano appartenere a un’epoca ormai perduta, quando l’attore – a differenza di oggi – era davvero centrale nei discorsi e nei consumi culturali del pubblico. Non stupisce dunque il finale metalinguistico, celebrativo e oltremodo ammiccante (l’ultima inquadratura è riservata a un’interpellazione verso lo spettatore con sguardo in macchina e frase ad effetto della star in cerca dell’eternità garantitagli dal cinema), apprezzabile più per i suoi risvolti teorici e la precisione esecutiva (difficile non commuoversi), che per la genuinità della scrittura (è evidente che l’obiettivo sia quello di condurre Clooney verso l’Oscar, in un film già di per sé celebrativo, se non agiografico).
Dunque, l’ennesimo film su un modo di fare cinema ormai perduto – e prodotto da Netflix in un paradosso editoriale che annovera anche i casi di Blonde e Mank – come chiarisce l’incipit virtuosistico, un pianosequenza che illustra la preparazione del set cinematografico, un processo descritto con euforia e bontà diffuse (anche troppo). Il risultato è però quello di una pellicola a metà, spesso troppo autoindulgente nei confronti dei propri personaggi e di sé stessa, una commediola limitata da una sceneggiatura (scritta a quattro mani da Baumbach e Emily Mortimer) a tratti turistica e ridicolmente antiquata: la lunga parentesi italiana spicca negativamente per l’abbondanza di cliché relativi alla rappresentazione della cultura del Belpaese e che possono essere giustificati (o solamente accettati) esclusivamente da quel processo di recupero nostalgico del cinema hollywoodiano classico, contesto in cui erano lo norma.