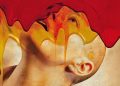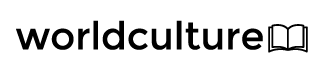Il mondo dell’arte è sempre pronto a stupirci con nuove scoperte e interpretazioni. Questa volta l’attenzione è caduta su uno dei capolavori più enigmatici del grande Sandro Botticelli (1445-1510): “La Calunnia”. Sono stati svelati infatti tutti i riferimenti nascosti nel quadro.

Svelato il mistero dell’iconografia
Un affascinante dipinto che affonda le sue radici nelle opere di Ovidio, Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio, ma i cui riferimenti erano rimasti celati fino ad oggi. Il mistero è stato finalmente svelato da due brillanti studiose dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav). Sono Monica Centanni, professoressa di Letteratura greca, e Sara Agnoletto, dottore di ricerca in Storia delle arti. Il loro libro “La Calunnia di Sandro Botticelli. Politica, vizi e virtù civili a Firenze nel Rinascimento”, pubblicato di recente da Officina Libraria, rivela per la prima volta i significati celati dietro questo straordinario dipinto del Rinascimento fiorentino.
Il quadro, esposto con orgoglio agli Uffizi, è un’opera complessa e dettagliata che ruota attorno a concetti cruciali come diffamazione e ingiustizia. Botticelli si ispirò a un dipinto leggendario di Apelle descritto da Luciano di Samosata, anche se non è certo che tale opera abbia mai esistito. Questo distacco tra testo e immagine ha da sempre ostacolato l’interpretazione della “Calunnia”.
La Calunnia: un’opera complessa sui concetti di giustizia e diffamazione
Grazie alla scoperta di nuove fonti testuali, le autrici ci guidano però attraverso un viaggio illuminante. La “Divina Commedia” ha ispirato la figura di Invidia e alcuni degli spazi architettonici del dipinto, con evidenti richiami alle Malebolge. Le “Metamorfosi” di Ovidio, invece, sono riconoscibili nei rilievi di Apollo e Dafne, Atamante e il giudizio di Paride, mentre la penna di Boccaccio influenza il riquadro dedicato a Cimone ed Ifigenia. La loggia si popola così di visioni letterarie, testimoniando l’incredibile abilità di Botticelli nel fonderle in un intricato labirinto di simboli e significati.
Le indagini di Centanni e Agnoletto hanno consentito di identificare tutte le immagini contenute nella sontuosa architettura che incornicia la scena principale. Il risultato è la classificazione di questo capolavoro come un vero e proprio “combattimento” tra i valori e i difetti del tempo. Il quadro si sviluppa in un contesto opprimente che seguì la morte del frate domenicano Girolamo Savonarola, il quale venne tragicamente bruciato sul rogo il 23 maggio 1498. Attraverso le immagini che si svelano nella tela, emerge un confronto serrato tra il bene e il male, un richiamo alla responsabilità civile e morale di quel periodo tumultuoso.