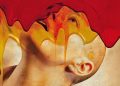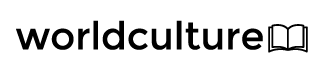Ari Aster, già regista di Hereditary (2018) e Midsommar (2019), torna per la terza volta dietro la macchina da presa con Beau ha paura, il suo film più ambizioso fino a ora.
Affrontare un progetto a medio budget è una novità per Aster, abituato a lavorare con finanziamenti ben più contenuti. In produzione c’è come sempre A24, casa di produzione fresca di Oscar al Miglior film per Everything Everywhere All At Once.
Ari Aster è riconosciuto sia dalla stampa che dall’industria cinematografica come un astro nascente del cinema horror contemporaneo. E spesso accostato a Jordan Peele (Get Out, Nope) e Robert Eggers (The Lighthouse, The Northman).
Questo trio di aspiranti maestri del genere ha stravolto Hollywood con le proprie opere prime. Ognuno di loro è arrivato al terzo lungometraggio. E avendo finalmente l’opportunità di lavorare con budget sbalorditivi mantenendo una discreta libertà artistica.
Tirando le somme, Aster è stato ben più capace dei suoi due colleghi ad addomesticare una situazione produttiva così ambiziosa.
Beau ha paura è, al di là delle critiche nelle quali stiamo per addentrarci, il frutto di una visione autoriale solida. E a questo punto, probabilmente inscalfibile.
Il cineasta newyorkese è stato in grado di preservare la propria identità. Adattando i temi portanti della propria poetica a una nuova dimensione produttiva. Sebbene abbia deciso di alzare l’asticella con questo film, non solo economicamente, soprattutto narrativamente.
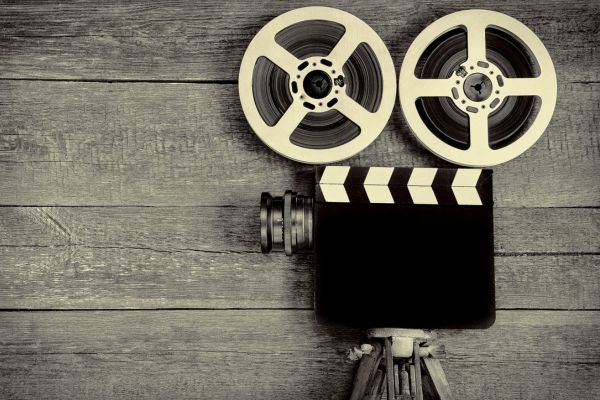
Una fiaba grottesca ricca di eventi irrazionali
Cercare di riassumere in poche parole la trama del film è improbabile, l’unica possibilità è quella di introdurre i temi del film.
Beau (Joaquin Phoenix) è un uomo sulla cinquantina che abita da solo in un appartamento fatiscente. In un quartiere malfamato di una metropoli indefinita, presumibilmente New York. Trascorre le giornate evitando i frequenti attacchi di panico e tentando di anestetizzare le proprie paranoie, per lo più legate all’ansia da contatto e all’agorafobia.
Una lunga catena di eventi irrazionali, quasi da fiaba grottesca, lo porterà a compiere un viaggio fisico e spirituale. E volto a farlo ricongiungere al ventre materno.
Le tre ore di durata gli consentono al regista di dividere la delirante odissea di Beau in quattro atti perfettamente omogenei in termini di durata e densità di contenuti, ognuno dei quali si differenzia palesemente dagli altri per scelte visive, temi trattati e toni assunti.
L’atto d’apertura è la manifestazione più palese del talento cristallino di Ari Aster alla macchina da presa. Avvalendosi di un montaggio psicotico, conduce il suo pubblico dentro le paranoie e le allucinazioni del protagonista. Ingabbiato in una città e in un contesto sociale al limite della distopia.
Il mondo creato da Aster sembra non conoscere il confine tra sano e grottesco.
Gli eccessi non mancano, eppure non superano mai la linea di demarcazione posta tra comicità disturbante e imbarazzo. In assoluto, i primi quaranta minuti di pellicola comunicano tutta l’ansia, il senso di colpa e lo spaesamento di Beau, dando vita a un’esperienza catartica come poche volte si è visto nella storia recente del cinema.
La durata del film, da molti bollata come “proibitiva” risulta, più che altro, prolissa in alcuni frangenti, in particolare nel secondo atto, che dimostra fin dalle prime immagini di avere ben poca carne al fuoco, protraendosi senza realmente far progredire la vicenda. Tuttalpiù diventa un pretesto per marciare su concetti e temi già sottolineati in precedenza.
Fortunatamente la seconda metà dell’opera si fa forte di una chiarezza di idee (filosofiche e cinematografiche) portentosa. Il disagio di Beau assume una forma “cartoonesca” in una sequenza onirica (a metà tra animazione e recitazione in carne e ossa) che sembra quasi convertire il film un libro di fiabe illustrato, proiettato direttamente sul grande schermo.
L’elaborazione del lutto, tema principale dei tre film di Ari Aster, in quest’opera ci viene raccontato attraverso due idee speculari: affrontare comunitariamente il dolore e, successivamente, affrontarlo faccia a faccia, per quanto possa essere devastante.
Ridurre a una manciata di frasi un’opera così densa di contenuti diventa sbrigativo: ciò che molti degli spettatori penseranno alla fine del film è che probabilmente necessita di una seconda visione più lucida.
Quello che parrebbe essere il cuore dell’opera tuttavia, è la sua natura allegorica.
Dietro questa fiaba psicotica si cela un animo più pacato, quello di una storia comune ai più: la genitorialità, letta sia dal punto di vista del figlio che, appunto, della madre.
Quello che per 180 minuti passa come “un’odissea nella mente di un uomo disturbato” si converte lentamente in una storia di conflitto tra un bambino mai cresciuto spaventato dal mondo e sua madre, donna tanto premurosa quanto opprimente.
Il filo rosso della storia resta il senso di colpa kafkiano del protagonista, esploratore dell’ignoto.
Nota di merito per la sequenza conclusiva del film, che se letta superficialmente mostra metaforicamente la mente del protagonista vista da una prospettiva esterna. Andando più in profondità però, sembra quasi voler essere una metafora sul ruolo dello spettatore cinematografico, che non è nient’altro che un voyeur chiamato a giudicare le vite degli altri, pur non sapendone niente, in fin dei conti.