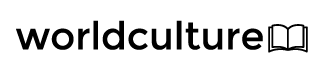Ce l’eravamo perso a Venezia 80, per grazia divina. Dogman di Luc Besson segna il ritorno del regista francese dopo la denuncia di stupro che lo ha visto coinvolto negli ultimi anni. Accolto tiepidamente in laguna, Dogman è di una banalità epocale, che sfocia molto (troppo) spesso nel ridicolo.
La storia, raccontata sottoforma di un lunghissimo flashback è quella di un uomo in sedia a rotelle, Douglas, da sempre relegato alla solitudine. I suoi unici compagni di vita sono i suoi cani. Grazie a loro, che insieme formano un branco pronto ad attaccare, Doug diventa un protettore per gli abitanti della zona in cui risiede, ricattando perfino la mafia locale.
Doug vive dell’amore dei propri cani, oltre che di rapine a opera dei suoi sgherri a quattro zampe. L’unica forma di svago che lo fa sentire vivo è la recitazione, che lo porta a entrare nel mondo degli spettacoli drag.
Per due ore ci vengono propinati discorsi sulla predestinazione insita nell’educazione cristiana. Doug, ereditando questa visione del mondo dal padre e dal fratello, due estremisti religiosi iper violenti, giustifica le proprie azioni amorali spacciandole per “volontà di Dio”.
Il fanatismo ideologico/religioso mostrato in questa maniera non fa altro che risultare imbarazzante per la superficialità con cui riempie la bocca del protagonista. Il film insiste talmente tanto su simbolismi religiosi da far venire, al termine della visione, il voltastomaco al solo pensiero di un crocifisso.
Doug si sente un Aristotele della criminalità nell’avere sempre la risposta pronta a qualsivoglia domanda di natura etica gli venga posta. In realtà agli occhi degli spettatori passa per un deficiente.

Prendere sul serio Dogman è complicato. Sembra scritto da un ragazzino che passa le giornate a divorare thriller anni 2010 di seconda mano. Eccessivamente enfatici e sensazionalisti in ciò che mostrano e sostengono. Besson, alla fin fine, è questo. Un bambinone al quale sono stati dati in mano diversi milioni di dollari.
Quello che tiene il pubblico incollato alla poltrona, però, è Caleb Landry Jones, il protagonista. Per fortuna questo ragazzo sta ricevendo le attenzioni che meriterebbe da anni, fin dai tempi di Antiviral di Brandon Cronenberg.
Jones è magnifico. La sua magnificenza passa nel riuscire a far sembrare quasi credibili le scemenze che gli sono state messe in bocca dallo sceneggiatore Besson. Il suo personaggio attraversa vari cambiamenti fisici radicali nel corso della propria vita, e il suo interprete lo ha assecondato, dimagrendo, ingrassando, facendosi crescere i capelli, truccandosi in continuazione.
Il passaggio di stato d’animo che Doug vive ogni qual volta indossi un abito di scena, che sia da Marylin Monroe piuttosto che da Edith Piaf, è tangibile, sentito.
Ecco, l’unica accezione positiva di Dogman sta nel concedere letteralmente un palcoscenico alle artiste drag, raccontando la libertà d’espressione di cui vivono, la loro linfa che si accumula, straripante, durante gli spettacoli.
Oltre ai rimandi aristotelici, Besson tenta di plagiare il tanto elogiato Joker del 2019. Ci sono almeno 20 inquadrature copiate pedissequamente dal film di Todd Philips. L’uomo abbandonato da dio e dagli uomini che riversa le proprie frustrazioni in un alter ego e nella criminalità. Stessa minestra, ma con meno sale.