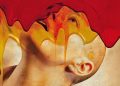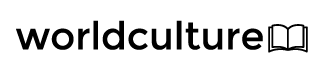Nelle precedenti edizioni il comun denominatore dei film d’apertura è stata la banalità. Quest’anno Comandante di Edoardo De Angelis inverte il trend negativo.
Scritto a quattro mani con Sandro Veronesi, il biopic sul generale della marina militare Salvatore Todaro spicca per alcune scelte narrative tanto rischiose quanto efficaci. Dopo il fallimentare La vita bugiarda degli adulti De Angelis aggiusta immediatamente il tiro confezionando la sua miglior opera.
Comandante è un’opera coraggiosa come il suo protagonista, figlio della solita interpretazione clamorosa di Pierfrancesco Favino. De Angelis sceglie di assumersi più rischi con questo film portandosi sulle spalle e sulla coscienza quelli che non vengono assunti ogni anno da produttori, sceneggiatori e registi. La sua opera cammina per 120 minuti su un filo sottile appeso tra due torri, (à la Philippe Petite per intenderci) sotto la corda c’è l’abisso di un ennesimo tentativo coraggioso andato a male prima del tempo. Per grazia divina, Comandante non è precipitato nell’abisso.
Sebbene parta sostanzialmente male, il racconto si aggiusta in corsa, passando da una sequela di inquadrature inutilmente pompose e scene “omaggio” ad altre opere fin troppo scontate, al trovare la propria identità politica.
Si parla di ventennio, ma non è quello il punto. Tanti, troppi colleghi parlano di film apologetico e francamente sembra surreale maturare pensieri simili dopo una visione che sa così tanto di libertà.
Il Todaro di Favino e De Angelis rivendica il suo stato di uomo di mare e, pertanto, uomo libero. Agganciandoci a un’altra opera fondante del cinema italiano recente (recentissimo), come in Martin Edendi Pietro Marcello il mare diventa il solvente con cui depurare la società dalle dinamiche classiste e opprimenti che la viziano.

L’opera in questione non fa apologia di fascismo, anzi. Lo mette in scena coi costumi di Massimo Cantini Parrini e le scenografie “sulla terra ferma” di Carmine Guarino, per poi fingere che non esista. Ignorare la macchia nera che si sparge rapidamente sull’Italia e sull’Europa è la risposta del regista al terrore del ventennio.
I personaggi che albergano nel sottomarino militare teatro della maggior parte del film, vivono come spettri, consci di essere già morti, non di star andando in pasto alla morte. La missione militare non viene presa sottogamba, è affrontata proprio come una condanna, un’esperienza pre mortem nella più rosea delle aspettative.
Alcuni personaggi secondari vengono sviscerati con monologhi interiori con un inaspettato approccio più alla Tarkovskij che alla De Angelis. Talvolta funzionano divinamente, talvolta non funzionano affatto. In generale però, la commistione tra epica bellica e ricerca di una dignità poetica dei personaggi è una scelta vincente.
Comandante di De Angelis è il sogno utopistico di un ragazzino che pensa alla guerra e alla xenofobia come fossero formiche messe sotto al microscopio: giganti solo all’apparenza, asfaltabili grazie a un cambio di prospettiva.
Il regista demiurgo sceglie a qualunque costo di dare un’immagine idealizzata e speranzosa degli uomini in guerra, in forte contrasto con le ideologie maggioritarie del nostro paese. Il coraggio è la virtù del film d’apertura di Venezia ’80, in grado di far passare sopra ad alcune imperfezioni, come ad esempio una fotografia sempre eccessivamente cupa o sovraesposta, per non parlare di effetti visivi troppo difficili da prendere sul serio.
La nota ambigua è una delle ultime battute pronunciate da Favino, che sembra voler correggere il tiro rispetto al messaggio antibellico e pacifista proposto fino a pochi minuti prima, come a voler trovare una soluzione che accontenti ogni visione ideologica salvandosi in calcio d’angolo all’ultimo minuto.