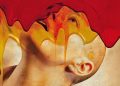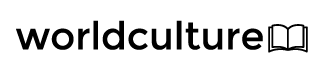Il ritorno di Paolo Sorrentino in Laguna è presto servito: quattro anni dopo il Leone d’argento vinto per È stata la mano di dio, La Grazia apre l’ottantaduesima Mostra del Cinema.
Toni Servillo interpreta Mariano De Santis, Presidente della Repubblica italiana che, a sei mesi dal termine del suo mandato, deve prendere tre decisioni cruciali: le prime due riguardano la concessione della grazia presidenziale a due controversi assassinii premeditati, la terza invece, interessa un disegno di legge per introdurre il suicidio assistito in Italia. Servillo è affiancato da Anna Ferzetti, che interpreta la figlia di De Santis, che come il padre è una giurista che dedica la sua vita professionale ed emotiva all’opera burocratica di suo padre in Quirinale.
Nell’opera di Sorrentino, l’affermarsi della pratica sulla teoria, è un rinnovarsi dell’animo umanista per i suoi personaggi, da sempre annichiliti e/o corrotti dal potere. In un certo senso La Grazia chiude una trilogia del potere iniziata da Il divo e Loro, biopic dedicati a Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi. Sarcasticamente, potremmo teorizzare che La grazia sia in prosecuzione un “biopic” fittizio su Sergio Mattarella.
Il potere, ossessione sorrentiniana della maturità, in questo nuovo lungometraggio, non è abusivo (o abusante), come nelle vite immaginarie di Andreotti e Berlusconi, ma possibilistico. Mariano De Santis, democristiano per sua stessa ammissione, dialogherà per centoquaranta minuti con il lutto, l’agonia e il passato, in cerca di una luce verso il futuro, un futuro sostenibile, fatto di consapevolezza.
Perché La grazia è il vero film della maturità di Sorrentino, il film della coscienza. Se le opere più celebri dell’autore napoletano (Le conseguenze dell’amore, La Grande Bellezza) erano mosse da un’esigenza comunicativa legata all’esistenzialismo e ai tormenti dell’uomo moderno, dunque passioni inconsce dell’autore che ne dettano gli stilemi poetici, gli ultimi tre lunghi (È stata la mano di Dio, Parthenope, La grazia) lavorano sulla coscienza dell’artista.
Raccontare del solito personaggio “alla Servillo”, anziano, benestante e disilluso, per poi condurlo verso una lenta redenzione emotiva, è anti-sorrentiniano. Sorrentiniano è ciò che resta invariato. La grazia, è un passaggio di stato. Quello del Sorrentino estetizzante al Sorrentino innamorato della giovinezza, non più di un’anzianità senza speranze. Alla pratica, piuttosto che alla teoria. Ma soprattutto all’attivismo, piuttosto che all’omertà.
Ponzio Pilato, ha smesso di lavarsi le mani. Sorrentino, vuole far emozionare ed emozionarsi. Mariano De Santis, vuole iniziare a sognare. Non ci riesce da quando ha perso sua moglie. Ci riuscirà soltanto nell’epilogo del film, ma lo farà con coscienza. Scegliendo consciamente cosa decidere di sognare, in ultimo commovente silenzio, galleggiando nell’aria.
La rivoluzione sorrentiniana, è approdata a Venezia.